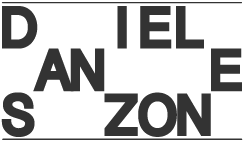Nicola Lagioia e La città dei vivi.

“La forza della letteratura è quella di illuminare zone, altrimenti in ombra, come nessun’altra disciplina riesce a fare.” A parlare è lo scrittore e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, Nicola Lagioia. A distanza di sei anni dal suo ultimo libro, “La ferocia” (Einaudi), che gli è valso il Premio Strega nel 2015, è tornato con “La città dei vivi” (Einaudi), il libro italiano del 2020 più votato dai 340 giurati nella Classifica di Qualità su La Lettura – Corriere della Sera. Armato con la torcia della parola, Lagioia ha provato a illuminare i neri abissi della natura umana interrogandosi/ci sui concetti di colpa, responsabilità e libero arbitrio. E lo ha fatto entrando anima e corpo in uno dei casi di cronaca nera più violenti degli ultimi anni: l’omicidio Varani. Manuel Foffo e Marco Prato, due ragazzi di buona famiglia, torturarono senza motivo per ore un ragazzo di 23 anni fino ad ammazzarlo. Una tragedia consumatasi, nel marzo del 2016, in un piccolo appartamento alla periferia di Roma, quartiere Collatino, a pochi chilometri da dove abita lo scrittore. Lagioia raccoglie le testimonianze dei protagonisti, si studia i documenti e incontra i genitori di Luca Varani, per arrivare al momento in cui tutto può succedere: il punto di non ritorno.
Cosa ti ha spinto a scrivere proprio questa storia e non un’altra?
È un po’ difficile rispondere nonostante abbia provato a farlo per tutto il libro senza mai dare una risposta definitiva. Sicuramente la violenza dell’omicidio, poi la mancanza di un movente – non c’è nessuna ragione, nessun vantaggio nell’uccidere Luca Varani – e il fatto che non si tratta di un omicidio maturato negli ambienti della criminalità. Sono stati considerati persone normali fino al giorno prima dell’omicidio, Manuel Foffo e Marco Prato potrebbero essere persone del nostro ambiente. E poi l’aspetto più inquietante è che entrambi siano consapevoli di quello che hanno fatto ma allo stesso tempo è come se fossero sorpresi di ciò di cui si sono resi protagonisti. Non riescono a interiorizzarlo e infine il fatto che tutto ciò sia accaduto ad appena venti minuti di motorino da casa mia. Uno pensa sempre che queste storie non entrino nel nostro spettro visivo. Questi sono solo alcuni degli elementi che mi hanno scaraventato nella ricerca che mi ha portato a scrivere questo libro.
Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
La parte emotivamente più coinvolgente, complicata e faticosa ma allo stesso tempo più gratificante e più capace di spalancarmi orizzonti, è stata la fase di ricerca. È stato davvero impegnativo anche dal punto di vista emotivo. La scrittura invece è stata paradossalmente più semplice perché sentivo talmente forte questo caso, che il sentimento mi faceva da bussola e quindi la scrittura sapeva molto bene dove andare. Forse la parte centrale è il vero baricentro del libro, dove c’è il ragionamento sul nostro approccio rispetto ai carnefici e alle vittime. Ecco quello non è stato difficile scriverlo, ma è stato difficile arrivarci. È stato il punto di arrivo di un percorso lungo. Capire come bisognerebbe amare la vittima e quale distanza avere dai carnefici, per me non è stato semplice. Ci sono arrivato attraverso la scrittura.
Nel libro passa l’idea che, quanto successo a Foffo e Prato, possa capitare a chiunque e che spesso è solo questione di fortuna. È davvero così sottile e labile la linea che divide il bene dal male?
Credo che il caso non di rado ci risparmi, come è successo a me negli anni turbolenti della mia adolescenza. In quel caso sono stato fortunato a non trovarmi in guai più seri di quelli in cui mi sono ficcato. Detto questo non credo sia stato soltanto un colpo di sfortuna il fatto che Marco Prato e Manuel Foffo abbiano fatto quello che hanno fatto, ma probabilmente se non si fossero mai incontrati non ci sarebbe stato nessun omicidio. Ho l’impressione che abbiano lavorato talmente male su loro stessi da rendere molto più probabile che ciò accadesse. Noi non ci conosciamo guardandoci allo specchio, ci conosciamo attraverso gli altri e questa mi sembra sia la fatica che loro non riescono a compiere. Se dicessi che è stato il caso toglierei peso alla loro responsabilità o alla loro colpa che invece c’è, esiste ed è molto pesante. Poi bisogna anche avere gli strumenti, una volta successa una cosa del genere, per poter attraversare il dolore che tutto ciò comporta. E appunto Maneul Foffo, che è l’unico rimasto in vita, non so se questi strumenti ce l’abbia.
Come hanno accolto il libro i familiari?
Ho mandato il libro a Manuel Foffo perché me l’ha chiesto, e poi gliel’ho mandato ai coniugi Varani dicendogli che non mi aspettavo che lo leggessero, perché potrebbe aggiungere dolore al dolore, ma l’ho fatto come atto di rispetto. Ai Prato invece non l’ho inviato perché mi è sembrato di capire che loro preferiscono il silenzio. E ovviamente non sono andato a chiedere cosa ne pensassero, mi sembrava poco sensato. Ho cercato di rispettare la postura di ognuno.
Inevitabile non pensare a “L’avversario” di Carrère e “A sangue freddo” di Capote, per citare i più famosi. Quanto ti hanno aiutato oppure condizionato questi due classici?
“A sangue freddo” e “L’avversario” sono dei libri importanti anche se il vero capostipite da questo punto di vista è “Compulsion” di Meyer Levin – pubblicato recentemente da Adelphi – da cui Hitchcock trasse il film, Nodo alla gola. In realtà per me sono stati importanti anche molti libri italiani che affrontano la realtà, in Inghilterra si chiama no fiction, ma in Italia questi esperimenti esistono da molto tempo. Pensa a Carlo Levi – “Cristo si è fermato a Eboli” – a “Se questo è un uomo” di Primo Levi, cos’è se non un’opera letteraria che indaga un fatto vero, terribile in quel caso, dove il male con la M maiuscola si interseca con la storia con la S maiuscola? Oppure “La scomparsa di Majorana” di Sciascia, “La Pelle” di Curzio Malaparte e ad alcuni racconti de “Il mare non bagna Napoli” di Anna Maria Ortese e così via. C’è una grande tradizione europea, italiana in particolare, sulle opere che indagano fatti veri. Questi per me hanno avuto un grande peso. Poi certo c’è la cronaca nera, ma quella credo d’averla presa più da Dostoevskij che da Capote o da Carrère.
In definitiva non credo che l’autore sia il miglior giudice delle opere che ha scritto.
Il libro non aggiunge niente ai fatti eppure nonostante si conosca la storia, ti rapisce. È questo il senso e la forza della letteratura?
Non credo che la forza di un libro consista nel fatto di farsi leggere facilmente. Credo che le opere letterarie siano capaci di illuminare aspetti della realtà che sfuggono allo sguardo dello storico, dell’antropologo, del sociologo, del criminologo e del giornalista. È questa la forza della letteratura: illuminare alcune zone, altrimenti in ombra, come nessun’altra disciplina riesce a fare.